Il lungo arco
temporale compreso tra il 1980 e il 2023 offre uno sguardo ricco di dettagli
sull’evoluzione della formazione dei medici in numerosi paesi, misurata in
laureati in medicina per 100 000 abitanti. All’inizio degli anni Ottanta
diverse nazioni presentavano livelli di ingresso nelle facoltà di medicina
piuttosto elevati, con alcuni picchi record, mentre altre registravano numeri
più contenuti. Nel corso dei decenni successivi il quadro si è fatto più
sfaccettato: a un’estensione e a un potenziamento delle politiche di
reclutamento hanno fatto da contraltare oscillazioni legate a riforme
accademiche, crisi economiche, ristrutturazioni dei sistemi sanitari e flussi
migratori di professionisti. Dall’analisi emerge un generale trend di aumento
della produzione di nuovi medici a livello mondiale, benché con intensità e
momenti diversi a seconda delle regioni e dei contesti nazionali, riflettendo
scelte politiche, bisogni demografici e dinamiche di mercato.
A livello
complessivo i paesi OCSE mostrano un incremento mediamente sostenuto del numero
di laureati in medicina per 100 000 abitanti: dove nel 1980 si attestava
attorno a valori medi inferiori a 10, già intorno al 2000 molte realtà avevano
superato quota 10, per poi spingersi oltre 12 o 15 punti nel decennio
successivo. Alcune nazioni caratterizzate da sistemi formativi più rigidi hanno
mantenuto nel tempo un andamento abbastanza piatta, mentre altre, spinte da
politiche di espansione universitaria, hanno fatto registrare incrementi
marcati soprattutto a partire dagli anni Duemila. In questo contesto la
convergenza verso una maggiore dotazione di medici per abitante appare chiara,
sebbene siano rimaste rilevanti differenze fra paesi che hanno adottato
strategie diverse in termini di numero programmato di iscritti e di durata e
costi degli studi.
Nel gruppo
anglosassone Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda
emergono traiettorie distinte anche se accomunate da una generale crescita.
L’Australia, che nel 1980 contava 9,33 laureati per 100 000 abitanti, ha visto
una lenta contrazione fino alla fine degli anni Ottanta, per poi invertire la
tendenza: dal 2000 in poi il numero di laureati è più che raddoppiato, toccando
punte superiori a 15 intorno al 2010 e stabilizzandosi attorno a quel valore
nella seconda metà del decennio. Il Canada ha mantenuto un profilo più stabile,
oscillando tra 5,8 e 7,8 laureati, con un lieve rialzo dopo il 2010 che ha
portato il valore verso quota 7,7. Negli Stati Uniti il dato iniziale di circa
7,1 nel 1980 è sceso lievemente fino a 6,3 intorno al 2000, per poi riprendersi
gradualmente, sorpassando 8 nel 2018 e attestandosi oltre questa soglia negli
anni più recenti. Il Regno Unito, privo di dati nei primi anni Ottanta, mostra
un aumento da 6,3 nel 1995 a picchi superiori a 13 all’inizio degli anni
Duemiladieci, per stabilizzarsi successivamente intorno a 13,5. Anche la Nuova
Zelanda presenta una crescita moderata, dall’intorno di 7 nei primi anni
Novanta a oltre 10 dal 2018.
I paesi nordici
hanno sperimentato dinamiche peculiari, con aumenti importanti in Danimarca e
in Svezia, mentre Finlandia, Norvegia e Islanda hanno avuto traiettorie più
ondulate. La Danimarca partiva da poco più di 12 laureati per 100 000 abitanti
nel 1980, ha conosciuto una fase di declino a metà anni Ottanta, per poi
accelerare con forza: tra il 2000 e il 2015 è passata da circa 11 a oltre 22,
stabilizzandosi infine poco sopra i 21–23. In Svezia l’incremento è stato più
graduale ma costante: da 10,5 del 1980 si è saliti a oltre 14,1 nel 2019, con
qualche flessione intermedia legata a riforme accademiche. Finlandia e Norvegia
hanno registrato flessioni attorno alla metà degli anni Novanta, con successivo
recupero; nel 2022 la Finlandia tocca oltre 13 laureati, mentre la Norvegia si
attesta intorno a 10,8. L’Islanda mostra picchi elevati già negli anni Ottanta
(oltre 24 nel 1986), seguiti da forti oscillazioni che la portano comunque a
valori compresi tra 12 e 16 nel ventennio successivo.
In Europa
continentale occidentale la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, la
Svizzera e l’Austria offrono esempi di diversi modelli di programmazione. La
Francia ha visto un calo da 16,6 nel 1980 a circa 5,7 nei primissimi anni
Novanta, riflettendo probabilmente tagli ai posti disponibili, seguiti da un
lento recupero che la porta intorno a 11,9 nel 2019. La Germania, priva di dati
completi fino al 1993, mostra un valore di partenza di 14,24 dopo la
riunificazione, seguito da un progressivo decremento fino a 10,6 nel 2000 e da
una stabilizzazione tra 11 e 12 nei decenni successivi. Il Belgio, i cui dati
diventano disponibili solo dalla metà degli anni Novanta, registra un aumento
da 9,85 nel 1994 a un picco anomalo di 28,78 nel 2019 – valore probabilmente
riconducibile a una variazione metodologica o a un’anomalia di registrazione –
per stabilizzarsi poi attorno a 17 negli anni immediatamente successivi. I
Paesi Bassi presentano un andamento crescente, da circa 10 nel 1983 a oltre
15,9 intorno al 2017, con qualche flessione moderata negli anni più recenti. In
Svizzera si osserva una lieve flessione nei primi anni Novanta, da circa 12,9
del 1980 a 9,6 nel 1994, seguita da una risalita che supera i 13 laureati nel
2019. L’Austria, che nel 1981 era già a 14,9, tocca 22,3 nel 1985 e poi alterna
fasi di regressione e ripresa, oscillando tra 13 e 22 fino al 2010 e
attestandosi attorno a 14,5–16 nei periodi più recenti.
I paesi
dell’Europa meridionale – Spagna, Italia, Grecia e Portogallo – hanno
attraversato trasformazioni significative, spesso in relazione alle crisi
economiche degli ultimi anni e alle riforme universitarie post-Bologna. La
Spagna parte da un valore elevato di 20,7 nel 1980, cala fino a circa 8,5 nella
metà degli anni Novanta, per poi risalire gradualmente fino a superare 14 tra
il 2015 e il 2018. L’Italia, i cui dati sono disponibili in modo più articolato
solo dopo il 2000, registra un incremento da 11,5 nel 2000 a valori superiori a
18,8 nel 2018, con una leggera flessione a 16,7 nel 2022. La Grecia,
caratterizzata da lacune informative, mostra comunque un passaggio da circa 9,6
del 1982 a oltre 13,5 nel 2005, con successive oscillazioni intorno a 12–14
fino al 2016. Il Portogallo evidenzia un innalzamento significativo dopo la
metà degli anni Novanta: da valori inferiori a 5 nel 1992 si passa a oltre 16
entro il 2017, per una crescita complessiva che testimonia l’ampliamento degli
accessi alle facoltà di medicina.
I paesi
dell’Europa dell’Est e postcomunisti – Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Slovacchia, Repubbliche baltiche e Romania – presentano alcuni dei più
clamorosi aumenti nel numero di laureati per 100 000 abitanti, spesso legati
all’ingresso nell’Unione Europea e all’allineamento ai programmi di mobilità e
standard formativi. La Polonia, da circa 9,5 nel 1980 scende a 6,0 nel 1998,
per poi risalire a 15,1 nel 2023. La Repubblica Ceca passa da 14,1 nel 1980 a
un minimo di 8,5 nel 1999, crescendo poi fino a 17,1 nel 2021. L’Ungheria
registra un lieve aumento dai valori intorno a 9 nel 1984 a 16,9 nel 2022. In
Slovacchia il profilo è più discontinuo, con oscillazioni tra 8 e 16 dal 1980
al 2015, per raggiungere infine 19,8 nel 2021. Le Repubbliche baltiche
forniscono casi estremi: la Lettonia scende a 3,59 nel 2000 e poi schizza a
27,51 nel 2023; la Lituania, partendo da 13,4 nel 1980, calava a 8,2 nel 1998 e
oggi mantiene valori oltre 20; l’Estonia, da 18,3 nel 1980, registra un minimo
di 4,43 nel 2000, per poi risalire a oltre 12 nel 2019. In Romania il dato
passa da 8,72 nel 1991 a 26,14 nel 2021, con una curva di crescita più marcata
dopo il 2005. Queste traiettorie riflettono la transizione economica e sociale,
nonché l’espansione delle università e dei finanziamenti pubblici alla
formazione medica.
Nel panorama
latinoamericano, paesi come Cile, Colombia e Messico mostrano un incremento
graduale ma costante. Il Cile, privo di dati fino al 2000, registra 4,61
laureati per 100 000 abitanti nel 2004, salendo sopra 9 entro il 2013 e
stabilizzandosi intorno a 11–12 negli anni più recenti. La Colombia passa da
6,03 nel 2001 a un massimo di 13,32 nel 2018, rimanendo sopra 11 fino al 2023.
Il Messico, senza dati antecedenti al 2000, parte da 9,3 quell’anno, cresce a
14,99 nel 2020 e compie oscillazioni attorno a 14. Questi aumenti sono in linea
con investimenti in istruzione superiore e con il tentativo di ridurre la
carenza di medici nelle aree rurali e suburbane.
Nel continente
asiatico e in Medio Oriente emergono scenari eterogenei. Il Giappone mantiene
un profilo stabile e contenuto: da 5,72 laureati nel 1980 si muove
nell’intervallo 6–7,5 fino al 2023, senza grandi picchi. La Corea del Sud
registra un valore di 7,67 solo dal 2000, crescendo fino a 9,33 nel 2004 e poi
stabilizzandosi intorno a 7,5–8,5. Israele, con dati completi solo dall’inizio
degli anni Novanta, oscilla tra 4 e 7,4, toccando i massimi più recenti nel
2021–2022. Turchia e paesi non OCSE come Romania, Bulgaria e Croazia mostrano
dinamiche di rapida crescita, ma nel caso turco il dato passa da 3,8 nel 1980 a
17,07 nel 2021; la Bulgaria salta da 7,78 nel 1994 a 29,49 nel 2021; la Croazia
oscilla tra 8 e 16,95 fino al 2023.
L’analisi rivela
come la formazione di nuovi medici si sia espansa in quasi tutte le regioni del
mondo, alimentata da esigenze demografiche di popolazioni sempre più anziane,
tensioni sul mercato del lavoro sanitario e, in molti paesi, da politiche di
accesso all’istruzione superiore più inclusive. Mentre in alcune nazioni
l’incremento è stato progressivo e lineare, in altre si sono susseguite fasi di
riforma accademica e variazioni nei programmi di reclutamento che hanno
determinato scostamenti e talvolta bruschi cali o picchi. La convergenza
tendenziale verso un numero di laureati per 100 000 abitanti compreso tra 10 e
20 rispecchia una spinta generale a garantire un adeguato rinnovamento
generazionale in una professione essenziale, sebbene permangano differenze
significative dovute a contesti economici, modelli di finanziamento degli studi
e politiche migratorie dei professionisti sanitari. Il percorso futuro potrà
dipendere dall’equilibrio tra domanda di assistenza, tecnologia medica, urgenze
sanitarie globali e sostenibilità dei sistemi formativi.
Fonte: OCSE
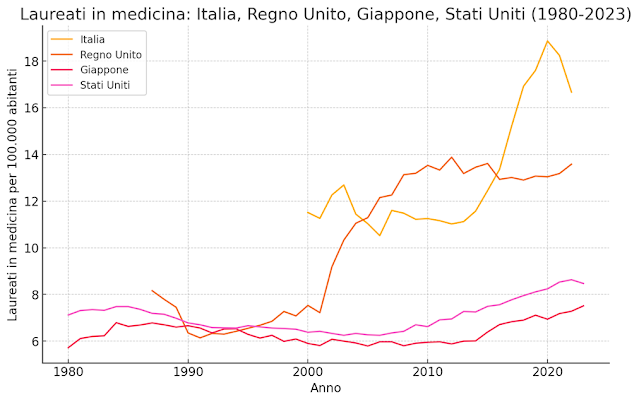
Commenti
Posta un commento