L'autonomia impositiva si riferisce alla capacità di un ente
territoriale, come una regione, una provincia o un comune, di stabilire,
gestire e riscuotere direttamente tributi e imposte sul proprio territorio.
Questa capacità include la possibilità di determinare le aliquote, le basi
imponibili e altre caratteristiche rilevanti per la tassazione, entro i limiti
stabiliti dalla legge nazionale. Un elevato grado di autonomia impositiva
implica che l'ente può finanziare una parte significativa delle proprie spese
attraverso le entrate derivanti da tributi locali, riducendo la dipendenza da
trasferimenti statali. Al contrario, una bassa autonomia impositiva indica che
l'ente si basa prevalentemente su risorse finanziarie trasferite dal governo
centrale o altri livelli di amministrazione. L'autonomia impositiva è spesso
considerata un elemento chiave del federalismo fiscale, in quanto consente agli
enti locali di adattare le politiche fiscali alle esigenze specifiche del
proprio territorio, promuovendo efficienza e responsabilità nella gestione
delle risorse pubbliche. I dati fanno riferimento alle province e città
metropolitane italiane tra il 2021 ed il 2022.
I dati relativi al grado di autonomia impositiva
delle regioni italiane nel 2021 e nel 2022 evidenziano una riduzione
generalizzata rispetto all'anno precedente. Questa tendenza è particolarmente
evidente in alcune regioni che nel 2021 registravano un livello di autonomia
fiscale significativamente alto, come Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, che nel
2022 hanno subito cali rispettivamente di 13,7, 15,7 e 26,5 punti percentuali.
Anche regioni come Lombardia, Veneto e Toscana mostrano cali marcati, indicando
una contrazione della capacità delle regioni di generare entrate proprie
tramite la fiscalità. Nel Nord Italia, il grado di autonomia impositiva risulta
generalmente più alto rispetto al Centro e al Sud. Tuttavia, anche le regioni
settentrionali hanno visto una diminuzione significativa nel 2022. Ad esempio,
la Lombardia, una delle regioni economicamente più forti, è passata dal 58,7%
del 2021 al 51,1% del 2022, mentre il Veneto è sceso dal 53,5% al 41,7%. La
stessa tendenza è osservabile per il Piemonte e l'Emilia-Romagna, che pur
mantenendo livelli superiori alla media nazionale, registrano riduzioni
importanti. Nel Centro Italia, l’Umbria ha subito una delle riduzioni più
marcate, passando dal 64,8% al 45,3%, seguita dalla Toscana e dal Lazio, che
mostrano cali più moderati. Le Marche, con una diminuzione di oltre 15 punti
percentuali, si allineano al trend generale della contrazione dell'autonomia
impositiva anche in quest'area. Nel Sud e nelle Isole, il quadro mostra una
minore capacità fiscale rispetto alle altre aree geografiche, ma anche qui si
osservano differenze significative tra le regioni. Abruzzo e Molise, che nel
2021 registravano un grado di autonomia tra i più alti del Paese, hanno visto
una drastica diminuzione rispettivamente di 26,5 e 16,7 punti percentuali.
Sicilia e Sardegna presentano una flessione meno accentuata, mentre regioni
come Calabria e Basilicata evidenziano cali significativi, scendendo sotto il
50%. A livello nazionale, il grado medio di autonomia impositiva è passato dal
58,1% nel 2021 al 48,3% nel 2022, segnando una contrazione di quasi 10 punti
percentuali. Questa tendenza riflette un possibile impatto di misure
centralizzate o di politiche economiche che hanno limitato la capacità delle
regioni di autofinanziarsi. La distribuzione geografica dei dati suggerisce
inoltre una persistenza del divario tra Nord e Sud, sebbene anche le regioni
settentrionali abbiano subito riduzioni significative.
Clustering
gerarchico. Il dendrogramma risultante dall’analisi di clustering
gerarchico delle città metropolitane e province delle regioni italiane in base
al grado di autonomia impositiva per gli anni 2021 e 2022 fornisce una
rappresentazione visiva delle similarità e delle differenze tra le regioni.
Questa metodologia permette di identificare raggruppamenti naturali basati
sulle caratteristiche fiscali delle regioni e consente di osservare il loro
posizionamento relativo nel contesto italiano. Le regioni con i valori più
bassi, come la Liguria, tendono a essere posizionate in cluster separati,
riflettendo la loro distanza dai valori medi o alti di autonomia impositiva. La
Liguria, con un grado di autonomia del 28,8% nel 2021 e del 27,1% nel 2022, si
distingue nettamente rispetto alla maggior parte delle altre regioni,
dimostrando una limitata capacità di generare entrate fiscali proprie. Questo
risultato può essere spiegato da una combinazione di fattori economici e
strutturali, come una base imponibile meno robusta e una maggiore dipendenza
dai trasferimenti statali. D’altro canto, regioni come Emilia-Romagna, Marche,
Molise e Abruzzo, che nel 2021 presentavano livelli di autonomia impositiva
superiori al 70%, formano cluster distinti caratterizzati da valori più alti
rispetto alla media nazionale. Tuttavia, si nota che il grado di autonomia di
queste regioni subisce una significativa riduzione nel 2022, portando alcune di
esse a raggrupparsi con regioni di autonomia intermedia, come Lazio e Toscana.
Questa tendenza evidenzia una contrazione generalizzata dell’autonomia fiscale,
che potrebbe essere attribuibile a fattori legati alla centralizzazione
fiscale, agli effetti economici della pandemia o a una redistribuzione delle
risorse finanziarie verso il livello centrale. Un altro gruppo interessante è
formato dalle regioni del Sud, come Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna,
che condividono valori moderati o bassi di autonomia impositiva. Queste
regioni, pur mostrando una certa eterogeneità interna, si raggruppano insieme
nel dendrogramma, riflettendo una situazione fiscale simile, con una limitata
capacità di autofinanziamento e una maggiore dipendenza dai trasferimenti
statali. Questo pattern può essere interpretato come il risultato di disparità
economiche e strutturali che caratterizzano il divario Nord-Sud in Italia. Le
regioni del Nord, come Lombardia, Veneto e Piemonte, che generalmente mostrano
livelli di autonomia impositiva superiori alla media nazionale, tendono a
raggrupparsi in cluster distinti, sebbene i loro valori siano diminuiti nel
2022 rispetto al 2021. Questo declino, visibile anche in altre regioni
settentrionali, suggerisce una tendenza generale di riduzione dell’autonomia
fiscale in tutto il Paese, con alcune eccezioni legate alle caratteristiche
peculiari di specifiche regioni. Infine, il dendrogramma evidenzia una
convergenza tra alcune regioni del Centro e del Sud, come Lazio e Campania, che
presentano valori intermedi di autonomia fiscale e mostrano pattern simili, pur
appartenendo a contesti geografici e socioeconomici diversi. Questo risultato
indica che le dinamiche fiscali delle città metropolitane e province delle
regioni italiane non sono interamente spiegabili dalle loro posizioni
geografiche, ma dipendono anche da fattori specifici legati alle politiche
regionali e al contesto economico. In conclusione, il clustering gerarchico
delle regioni italiane in base all’autonomia impositiva rivela importanti
differenze e similitudini tra le regioni, riflettendo il complesso panorama
fiscale del Paese. La generale contrazione dell’autonomia impositiva nel 2022
evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente le dinamiche che hanno
guidato questi cambiamenti e di considerare interventi politici mirati per
rafforzare la capacità fiscale delle regioni, in particolare quelle con
maggiore difficoltà.

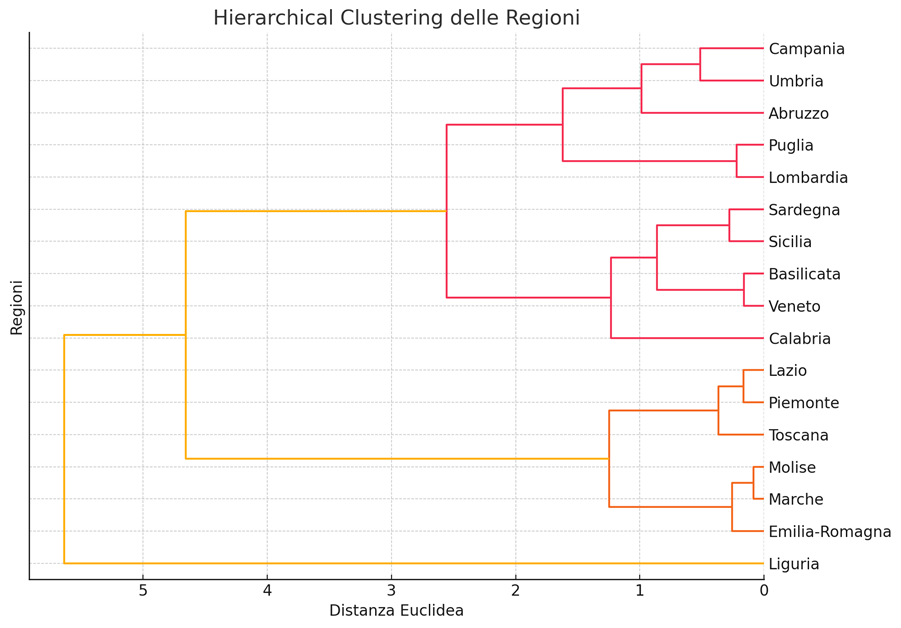
Commenti
Posta un commento